Le cliniche legali, sin dalla loro primissima formulazione, hanno avuto la finalità di curare persone in condizioni di vulnerabilità sociale e giuridica. Secondo la ricostruzione che Richard Wilson ne propone nel volume “The global evolution of clinical legal education. More than a method” (2019), la prima clinica legale è stata attivata presso l’Università della Pennsylvania alla fine del 1800, con la denominazione di law dispensary, per analogia con la missione generalmente svolta dagli ambulatori medici di fornire assistenza morale e materiale a persone indigenti. Fonti statunitensi documentano l’esistenza parallela di cliniche legali in Europa (in Germania, in Russia e in Olanda), contrastando lo stereotipo secondo cui le cliniche legali sarebbero un’invenzione esclusivamente americana. Malgrado l’avvio rivoluzionario, le cliniche legali si diffonderanno nelle università statunitensi solo più tardi, tra gli anni 1960 e 1970, come espressione dell’impegno dei giuristi clinici rispetto alla giustizia sociale, soprattutto in termini di rivendicazione dei diritti delle minoranze.
In Europa, la diffusione delle cliniche legali avverrà in concomitanza con i processi di riforma dell’istruzione superiore, in particolare dalla riforma di Bologna degli anni 1990 in poi, con l’obiettivo di contribuire alla professionalizzazione dei percorsi di studio nelle Facoltà di Giurisprudenza e realizzare una maggiore connessione con il contesto sociale di operatività delle Università.
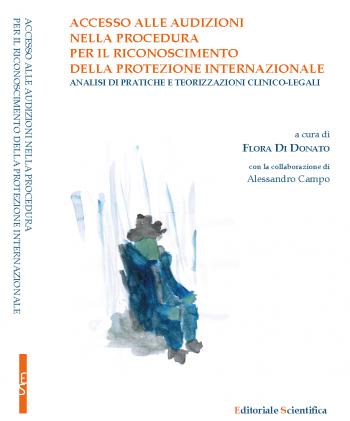
Le cliniche legali si propongono infatti non solo come un percorso pratico (learning by doing) ma anche come una sfida etica e deontologica per docenti e studenti che mettono le proprie competenze al servizio di persone e gruppi socialmente e legalmente vulnerabili, favorendone l’accesso ai diritti e alla giustizia. Come nel caso delle cliniche legali statunitensi, la promozione della giustizia sociale è al centro del movimento delle cliniche legali sia europee che italiane.
Nel nostro Dipartimento di Giurisprudenza, Il primo step verso la creazione di una Clinica legale è stato rappresentato dall’attivazione, nel 2017, di un insegnamento di Formazione clinico-legale, a titolarità della Prof. Flora Di Donato, con le finalità di:
1. offrire agli studenti un laboratorio di analisi casistica creando un ponte con istituzioni esterne: Tribunali, Commissioni territoriali, studi professionali, organismi internazionali, cooperative sociali, associazioni di volontariato. Gli studenti, preventivamente formati in aula, in collaborazione con operatori specializzati nei diversi settori di intervento, offrono supporto legale (legal aid), redigendo atti, contribuendo alla stesura di decisioni, rimuovendo ostacoli amministrativi. La gestione di casi reali consente loro di praticare e vivere il diritto, acquisendo competenze e abilità, a contatto con persone in condizione di marginalizzazione.
2. stimolare un approccio interdisciplinare nello studio e soluzione dei casi, dialogando con ricercatori di altre discipline (psicologi sociali; sociologi; antropologi; esperti di educazione);
3. ideare azioni di empowerment per persone giuridicamente vulnerabili, come richiedenti asilo, apolidi, persone con disabilità o senza fissa dimora.

L’attivazione di un primo sportello clinico-legale (denominato Statelessness Legal Clinic) è avvenuta nel 2021 grazie al supporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) con il mandato di regolarizzare lo statuto civico di persone apolidi o a rischio apolidia nel territorio campano.
Nel 2025 ha avuto luogo l’attivazione di un secondo sportello destinato all’ascolto e all’orientamento dei richiedenti asilo, all’interno dell’ambulatorio sociale denominato Casa Bartimeo, grazie al supporto dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini, con sede a Napoli.




























